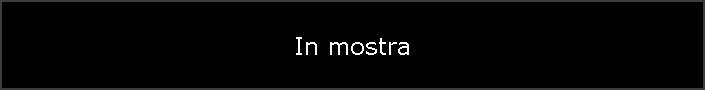|
Thomas Harriot
il primo osservatore telescopico
Nota: tutte le date sono in
calendario gregoriano. Anche se all’epoca l’Inghilterra adottava
ancora quello giuliano, la scelta è stata fatta per un criterio di
omogeneità ai fini del possibile confronto con le osservazioni
effettuate negli altri paesi e con le circostanze osservative
fornite dai vari software planetari.
Nel 2009, Anno Internazionale
dell’Astronomia, si è parlato molto, ovviamente, dell’invenzione del
telescopio e delle prime osservazioni con questo strumento. Fra
coloro che puntarono per primi un telescopio al cielo vi fu
l’inglese Thomas Harriot (fig. 1). Sulla riscoperta della vita e
delle opere di questo straordinario contemporaneo di Galileo, i cui
contributi sono stati per molto tempo avvolti nel mistero, è stato
fra l’altro incentrato l’intero Anno nel Regno Unito.

Fig. 1. Si pensava
che questo dipinto del 1602, secondo una tradizione dei
primi del '900, ritraesse Harriot, ma un restauro
del 1957 rivelò la dicitura visibile sull'età del personaggio
effigiato, 32 anni,
10 in meno dell’età di Harriot all’epoca (Trinity College,
Oxford).
Thomas Harriot nacque nel 1560 ad
Oxford, ma non si conosce la precisa data di nascita, né i nomi e le
occupazioni dei genitori. Frequentò il St Mary’s Hall (fig. 2), uno
dei college afferenti all’Università cittadina, dove conseguì il suo
baccalaureato nel 1579, acquisendo un bagaglio particolarmente
approfondito nel campo della matematica.

Fig. 2. La St Mary’s
Hall, dove si laureò Harriot, in un’incisione del 1675 di David
Loggan.
In quegli anni l’Inghilterra si stava
avviando a diventare la seconda potenza europea, dopo la Francia.
Già dai tempi di Enrico VIII aveva cominciato ad affermarsi come
potenza mercantile e marinara, ed era entrata in urto con la Spagna,
sia in varie zone dello scacchiere europeo sia nelle rotte
atlantiche. Nel 1558 era salita al trono la giovane figlia di Enrico
VIII e Anna Bolena, Elisabetta I (fig. 3), che completò l’opera del
padre, sbaragliando l’enorme flotta, l’Armada Invencible,
che il sovrano spagnolo Filippo II aveva inviato a invadere
l’Inghilterra e deporne la regina.

Fig. 3. Ritratto di
Elisabetta I (Darnley Portrait) realizzato intorno al 1575, quando
la sovrana aveva 42 anni (Londra, National Portrait Gallery).
Da quel momento iniziò il declino
della Spagna e l’irresistibile ascesa dell’Inghilterra sul proscenio
mondiale. Il Paese era permeato di febbrili attività mercantili e
marinare, sorrette, come sempre avviene nelle fasi di espansione
economica, dal fiorire della scienza, delle lettere, delle arti. I
suoi capitani, dotati di notevoli capacità tecniche, espansero i
commerci su tutte le principali rotte mondiali, comprese quelle
americane, dove erano in concorrenza con le navi francesi e
spagnole. Non si facevano scrupolo, come è noto, di ricorrere anche
alla guerra di corsa pur di compiere i loro guadagni. Alcuni di
questi corsari, come Martin Frobisher e Francis Drake, famoso il
primo per la ricerca del Passaggio a Nord Ovest, il secondo per aver
compiuto la seconda circumnavigazione del globo, furono anche tra i
fautori della sconfitta dell’Armada spagnola. Un altro
corsaro famoso fu Walter Raleigh (fig. 4), del quale Harriot
divenne, nel 1583, il pupillo.

Fig. 4. Ritratto di
Sir Walter Raleigh eseguito da Nicholas Hilliard nel 1585, all’età
di 33 anni (Londra, National Portrait Gallery).
Raleigh era tuttavia ben più di un
corsaro. Di otto anni più vecchio di Harriot, oltre che uomo
d’azione, era un aristocratico nelle grazie della Regina, un
letterato di chiara fama, un uomo dalla profonda cultura e dai
molteplici interessi giunto, nei primi anni Ottanta del Cinquecento,
all’apice della sua fama, una delle personalità più importanti
dell’epoca elisabettiana, di fatto il principale iniziatore
dell’espansione coloniale britannica. Harriot fu impiegato da
Raleigh nella progettazione e nella costruzione delle sue navi e
nella scelta del suo equipaggio, ma soprattutto nella risoluzione
dei problemi di astronomia nautica. In particolare si occupò di
compilare tavole aggiornate di declinazione del Sole, di
semplificare la raccolta delle misure di altezza del Sole, della
Polare e delle altre stelle per determinare la latitudine, e
introdusse l’idea di usare l’amplitudine solare o di una stella per
determinare la declinazione magnetica. Egli tenne su questi temi
delle lezioni a cui partecipavano i capitani e i piloti di Raleigh,
oltre a Raleigh stesso e ai suoi amici, a Durham House, a Londra, la
residenza di Raleigh dove il matematico viveva in quel periodo. Ne
realizzò anche un manuale che veniva dato in dotazione a bordo delle
navi, Arcticon, che però non venne mai pubblicato e di cui
non è mai stata trovata traccia. Secondo lo storico John Roche,
grazie ad Harriot Raleigh aveva a quel tempo a disposizione la
migliore scienza nautica nell’intera Europa.
Nella cerchia di Raleigh erano
comprese alcune fra le menti più importanti del periodo, come John
Dee, potente astronomo e astrologo di corte, e Thomas Digges, primo
diffusore delle idee copernicane in Inghilterra (fig. 5). Attraverso
Raleigh, Harriot conobbe anche William Gilbert, medico della regina,
fondatore dello studio scientifico del magnetismo.
 Fig.
5. L’universo copernicano secondo Thomas Digges
(da A perfit description of the
caelestiall orbes, Londra, 1576). Andando
al di là di Copernico, che immaginava ancora le stelle fisse tutte
ugualmente lontane, Digges le colloca a distanze variabili dal Sole. Fig.
5. L’universo copernicano secondo Thomas Digges
(da A perfit description of the
caelestiall orbes, Londra, 1576). Andando
al di là di Copernico, che immaginava ancora le stelle fisse tutte
ugualmente lontane, Digges le colloca a distanze variabili dal Sole.
Ottenuta da Elisabetta una patente
che gli conferiva ampi diritti sulle terre comprese fra i 35° e i
45° di latitudine, Raleigh organizzò varie spedizioni per la
colonizzazione dell’America. Nel 1584 fondò sulle coste
settentrionali del continente la prima colonia britannica sul suolo
americano, chiamandola Virginia, in onore della sovrana rimasta
nubile. L’anno successivo vi fece ritorno portando con sé, per le
sue competenze astronomiche e topografiche, anche Harriot. Fra
l’altro, dopo dieci giorni dalla partenza, il 29 aprile 1585, lo
scienziato osservò un’eclisse di sole al tramonto. Si trattava di un
particolare tipo di eclisse, ibrida, cioè anulare-totale (fig. 6),
ma visibile soltanto come anulare, e di breve durata, nella zona
dell’Atlantico dove si trovavano le navi. È possibile ipotizzare,
poiché il fenomeno non era visibile dal continente europeo, che la
partenza sia stata programmata in quei giorni per poterlo studiare.
 Fig. 6.
Percorso dell’eclisse di Sole del 1585 osservata in alto mare da
Harriot (Fred Espenak e Jean Meeus/NASA/Google/Xavier M. Juber). Fig. 6.
Percorso dell’eclisse di Sole del 1585 osservata in alto mare da
Harriot (Fred Espenak e Jean Meeus/NASA/Google/Xavier M. Juber).
Harriot si fermò per circa un anno e mezzo in Virginia ed ebbe il
tempo di osservare usi e costumi dei nativi Algonchini e di
impararne la lingua. Ne diede conto in A brief and true report of
the new found land of Virginia, pubblicato nel 1588, che è da
ritenersi a tutti gli effetti la prima opera di antropologia
culturale.
Quando fece ritorno dall’America, si recò in Irlanda, in veste di
amministratore dei possedimenti che Raleigh vi aveva, e di uno dei
quali il suo protettore gli fece dono. Per qualche anno visse in
Irlanda, anche grazie alle rendite che la proprietà gli assicurava,
ma poi ritornò in Inghilterra, e vendette la tenuta nel 1597. Nel
1592 la fortuna aveva però voltato le spalle al grande navigatore.
L’anno prima, infatti, sir Walter aveva sposato Elizabeth
Throckmorton, dama di compagnia della regina, ma in segreto e senza
chiederne l’autorizzazione reale com’era d’obbligo. Quando il
matrimonio fu scoperto, la dama fu allontanata dalla corte e Raleigh
fu incarcerato. La prigionia durò poco tempo, ma ormai il cavaliere
era caduto in disgrazia e, poiché non voleva coinvolgere i suoi
protetti nelle proprie disavventure, raccomandò Harriot ad un nuovo
mecenate, Henry Percy, Conte del Northumberland. Costui era
conosciuto anche come The Wizard Earl, a causa della sua passione
per la scienza, l’alchimia e la cartografia e la sua sterminata
biblioteca: le cronache raccontano che spendeva 50 sterline l’anno,
circa 125 000 euro attuali, per acquistare libri. Era amico di
letterati come Christopher Marlowe e John Donne e del citato John
Dee.
Sotto l’ala di Percy si costituì un trio di filosofi, che
comprendeva anche Walter Warner e Robert Hues, chiamati i Tre Magi,
nel quale Harriot rappresentava il Mago “anziano”, che godeva di
molta libertà creativa e aveva l’unica incombenza di intrattenere e
conversare con il conte su ogni sorta di tematica. I due filosofi
“minori” ricevevano un emolumento di 60 sterline l’anno, mentre
Harriot riceveva una somma doppia, pari più o meno, a 300 000 euro
(curiosamente molto simile a quanto ricevette Galileo dal Granduca
di Toscana a partire dal 1610). Assieme a varie tenute e case,
questa somma gli fu elargita fino alla morte, e gli permise di
dedicarsi senza nessuna preoccupazione ai suoi studi. Il conte gli
diede anche in uso Syon House (fig. 7), una favolosa residenza
circondata da una tenuta di 80 ettari nella periferia di Londra, che
egli usò sia come dimora che come laboratorio scientifico a partire
dal 1597.
 Fig. 7.
La Syon House oggi (Russ Hamer). Fig. 7.
La Syon House oggi (Russ Hamer).
Negli anni Novanta Harriot si occupò di varie questioni matematiche.
Ancora quando era con Raleigh era stato invitato da questi a
dedicarsi a un problema tipicamente militare, stabilire la vera
traiettoria di un proiettile di cannone. Affrancandosi dalla fisica
aristotelica ancora dominante, lo scienziato riuscì a scomporre la
traiettoria in una componente verticale ed una orizzontale, comprese
che la resistenza dell’aria influiva sull’intera fase di volo, e che
la gravità agiva sulla componente verticale. Arrivò molto vicino ad
una soluzione dell’analisi vettoriale del problema di trovare la
velocità del proiettile e infine, nel 1607, giunse anche alla
conclusione che la traiettoria fosse una parabola inclinata.
Si
occupò anche di ottica, misurando l’indice di rifrazione di vari
liquidi contenuti in un prisma di vetro cavo. Risolse il cosiddetto
problema di Alhazen, ovvero la ricerca del cammino che un raggio
luminoso deve percorrere (in un mezzo omogeneo) per giungere
all’occhio da una sorgente data, dopo aver subito riflessione su uno
specchio sferico. Alcuni pensano che per risolvere la questione
Harriot abbia usato delle tecniche basate sul calcolo
infinitesimale, introducendo idee che furono riprese decenni dopo
dal grande matematico Isaac Barrow, professore di Newton a
Cambridge. Inoltre in seguito, nel 1601, scoprì la legge che
descrive le modalità di rifrazione di un raggio luminoso nella
transizione tra due mezzi con indice di rifrazione
diverso, oggi nota come legge di Snell, il matematico olandese che
la trovò vent’anni più tardi.
Si
occupò intensivamente anche di chimica, per circa un anno, dal
maggio 1599 al maggio 1600, ma a quanto sembra senza conseguire
risultati originali.
Sempre negli anni Novanta Harriot
compì numerose osservazioni con il più grande dei suoi radii
astronomici, lungo ben dodici piedi (3,65 m), per ottenere una
misura precisa della distanza della Stella Polare dal polo nord
celeste (che in quel periodo era di quasi tre gradi). Si trattava di
un’esigenza irrinunciabile soprattutto per i naviganti. Topografi e
astronomi, infatti, non avevano problemi a trovare il nord vero con
altri metodi e strumenti, ma la cultura media dei marinai consentiva
loro di compiere soltanto osservazioni relativamente semplici, come
appunto prendere l’altezza della Polare. Una volta che era
conosciuta la vera distanza della stella dal Polo era abbastanza
agevole, con tavole o diagrammi, trovare il nord vero. Il radio
astronomico (fig. 8) era una versione della balestriglia,
strumento inventato nel Medioevo e costituito da due regoli di
diversa lunghezza. Il regolo corto era montato a croce a cavallo del
regolo lungo e scorreva su di esso. Mentre la balestriglia serviva
per misure di altezza, il radio misurava l'angolo di separazione fra
due astri: posto l'occhio a un’estremità del regolo lungo si faceva
scorrere il regolo corto finché le estremità, munite di mire,
sfioravano i due astri. Il rapporto fra la lunghezza del regolo
corto e la sua distanza dall’occhio permetteva, grazie a una tavola
delle tangenti, di ricavare l’angolo di separazione fra i due astri.
In altre versioni il regolo lungo era direttamente graduato.
 Fig. 8.
L’utilizzo
della Cross Staff (da Willem Janszoon Blaeu, Le flambeau de la navigation,
Amsterdam, 1619). Fig. 8.
L’utilizzo
della Cross Staff (da Willem Janszoon Blaeu, Le flambeau de la navigation,
Amsterdam, 1619).
Al
di là degli aspetti nautici, però, l’astronomia interessava Harriot
soprattutto per i suoi intimi rapporti con la matematica. Come
Thomas Digges e William Gilbert, era fortemente attratto dalla
semplicità e dall’eleganza matematica dell’universo eliocentrico di
Copernico.
Nel
1603, con la morte di Elisabetta, le cose sembrarono cambiare
radicalmente in Inghilterra. Il nuovo re Giacomo I fece arrestare
Raleigh con l’accusa di cospirare contro di lui. Un sommario
processo ne decretò la condanna a morte. Tentò il suicidio, ma
fallì. Allora chiese ad Harriot di testimoniare in suo favore, ma
non ci fu nulla da fare, la pena venne confermata e lo stesso
Harriot sospettato di essere ateo e di avere un’influenza maligna
sul condannato. Il matematico fu terribilmente turbato da tutto ciò
e per circa un anno non fu in grado di dedicarsi a nessun lavoro
scientifico. Raleigh ricevette però all’ultimo momento la grazia,
che fu commutata in una reclusione a vita nella Torre di Londra. Nel
1605 anche il secondo protettore di Harriot, Percy, fu arrestato,
con l’accusa di essere stato a conoscenza della Congiura delle
Polveri, a cui aveva partecipato anche il nipote Thomas, e di non
averne avvertito le autorità. Fu rinchiuso anch’egli nella Torre, da
dove uscì solo nel 1621. Perfino Harriot fu sospettato di essere
ostile al re, in quanto aveva redatto un oroscopo per Giacomo I che,
secondo gli inquirenti, aveva l’obiettivo di influenzarne la
politica. Per questo, fu imprigionato e rilasciato solo dopo tre
settimane.
Dopo il rilascio, egli si occupò soprattutto di ottica, studiando la
dispersione della luce nei vari colori e cominciando a sviluppare
una teoria sul fenomeno dell’arcobaleno. Keplero venne a conoscenza
dei suoi studi, e per qualche tempo fra i due vi uno scambio di
corrispondenza, che non portò però a feconde conclusioni a causa,
pare, della reticenza dell’inglese sui propri risultati.
Prima dell’avvento del telescopio, come astronomo pratico Harriot si
occupò soprattutto di comete, osservandone una decina. Egli a quanto
pare usò sempre, come strumenti, radii astronomici di varie
dimensioni, anche se non così grandi come quello prima citato. Con
questi riusciva a misurare angoli fino a due arcominuti. Celebri
sono le sue osservazioni fotometriche e astrometriche della cometa
del 1607, che altri non era che la Halley (fig. 9).
In quel passaggio la sua testa raggiunse la magnitudine 0 e la sua
coda risultò lunga 8-10°, fu vista da astronomi del calibro di
Keplero, Longomontano, Benedetto Castelli, ma quelle di Harriot, che
osservò da Syon House assieme all’amico, cognato di Percy, William
Lower, furono di gran lunga le osservazioni più complete e precise.
Quando F.W. Bessel, nel 1808, riuscì a ricostruire gli elementi
orbitali di quel passaggio, utilizzò solo un’osservazione di Keplero
e una di Longomontano, ma ben otto di Harriot.

Fig. 9. La cometa del 1607
raffigurata nella Cometographia di Hevelius (Danzica, 1668).
Il
telescopio, com’è noto, fu inventato nei Paesi Bassi nel settembre
del 1608. Da lì, rapidamente, la notizia del nuovo ritrovato e anche
la capacità di replicarlo si propalò per tutta l’Europa. Galileo ne
sentì parlare per la prima volta nel maggio del 1609 e nel mese di
agosto fu in grado di costruire uno strumento di potere simile a
quelli olandesi, nove ingrandimenti, che presentò al governo
veneziano il 21 del mese.
In un
bollettino stampato a L’Aja nel 1608 si affermava che il telescopio
era stato anche puntato verso il cielo e che “…le stelle che
ordinariamente non appaiono alla nostra vista … si possono vedere
per mezzo di questo strumento.”, ma non sappiamo chi e quando abbia
compiuto questa esperienza. Galileo, d’altra parte, non usò subito
il telescopio come strumento astronomico, e le prime sue
osservazioni datate, come si desume dal
Sidereus nuncius, sono del 7 gennaio 1610, data in cui scoprì
i primi tre satelliti di Giove. È stato anche sufficientemente
chiarito come sia impossibile datare i disegni lunari del
Sidereus, dal momento che essi corrispondono ad un’impressione
di massima di come appare la Luna nelle diverse fasi, piuttosto che
essere la riproduzione di particolari realmente esistenti visibili
in una fase particolare, anche se è probabile che Galileo iniziasse
le sue osservazioni almeno da ottobre 1609, perché in quel mese
aveva mostrato la Luna al granduca Cosimo II. Invece, Harriot lasciò
scritto nei suoi appunti che rivolse un telescopio olandese da sei
ingrandimenti verso la Luna la sera del 5 agosto 1609. Quindi, senza
alcun dubbio, la sua è la prima osservazione registrata di un
qualsiasi corpo celeste effettuata al telescopio.
Non sappiamo come Harriot si procurò
lo strumento, anche se è probabile che si trattasse proprio di uno
strumento di fabbricazione olandese importato. Diversi autori,
soprattutto inglesi, hanno affermato che vari passi di scienziati di
epoca elisabettiana, Leonard e Thomas Digges, Robert Recorde, John
Dee, William Bourne, lo stesso Harriot, farebbero pensare che un
qualche tipo di telescopio fosse stato inventato in Inghilterra
prima del 1588 ma, ad un esame più accurato, si comprende come le
loro fossero soltanto speculazioni su ciò che si sarebbe potuto
fare, non su ciò che era già stato fatto, utilizzando lenti e
specchi, non più lenti, e meno che meno lenti concave, come quelle
utilizzate per l’oculare dei telescopi olandesi.Il passo che
riguarda Harriot è il riferimento al fatto che, quando si trovava in
Virginia, aveva mostrato agli Algonchini incuriositi tutto il suo
armamentario di strumenti scientifici, incluso a perspective
glasse whereby was shewd manie strange sightes. Ora, se andiamo
a vedere su un dizionario di riferimento come il Webster scopriamo
che un perspective glass è “un telescopio che mostra gli
oggetti nella giusta posizione”, probabilmente, si intende, un
telescopio raddrizzatore, terrestre, ma questa è una locuzione
moderna, entrata in uso dopo il Rinascimento, forse nel settecento
(la usa Daniel Defoe in Robinson Crusoe). Harriot può aver
voluto indicare qualunque cosa, a partire proprio dal significato
più comune dei due termini separati, “vetro” e “prospettico”, forse
una lente che deformava gli oggetti, e così si spiegherebbe anche
perché mostrava “molte strane visioni”, non ingrandite, non vicine,
strane, appunto. D’altra parte, anche il secondo significato
riportato dal Webster per perspective glass giustifica questo
assunto: “qualsiasi dispositivo ottico in grado di fornire un
effetto fantastico o un’illusione ottica”. In ogni caso il
cosiddetto “telescopio dei Tudor”, di cui hanno parlato anche
giornali non specialistici, è una grossa bufala, come riconoscono
del resto anche gli autori inglesi più avveduti.
Certo, il primo telescopio di Harriot
doveva essere molto scadente perché, nel disegno che egli fece della
Luna, si vede meno di quanto si possa scorgere a occhio nudo sul
nostro satellite (fig. 10). A differenza di Galileo, quindi,
probabilmente egli non capì ciò che stava guardando, ovvero mari,
vallate e montagne appartenenti ad un altro mondo, simile al nostro.
Forse si può immaginare ciò che pensò leggendo quanto gli scrisse
Lower il 16 febbraio 1610, dopo aver osservato a sua volta per
diversi mesi la Luna dalla sua tenuta di Traventi, nel Galles: “Nel
complesso essa somiglia a una torta che mi fece la mia cuoca la
settimana scorsa; una macchia di sostanza luminosa qua, e una
macchia di sostanza scura là, e così dappertutto, confusamente.”

Fig. 10.
La Luna raffigurata da Harriot il 5 agosto 1609, a sinistra, a
confronto con un disegno effettuato a occhio nudo dall’autore una
decina di anni fa.
Nell’inverno 1609-1610, quindi contemporaneamente a Galileo, William
Lower osservò al telescopio anche le Pleiadi e la zona della spada
di Orione, come risulta da una lettera scritta ad Harriot il 23
giugno 1610. Anche il suo telescopio, però, non doveva essere dei
migliori, perché nelle Pleiadi scorse solo sette stelle, mentre
Galileo ne aveva viste una quarantina.

Fig. 11. Mappa della
Luna realizzata da Harriot nel 1611. Nell’originale il diametro
lunare è di 15 cm. Vi sono 72 particolari annotati con lettere
dell’alfabeto e numeri da 1 a 50. Queste indicazioni tuttavia non
corrispondono a una legenda ma, stando alle note che accompagnano la
mappa, sembrano costituire punti con relazioni geometriche fra loro.
Nelle note vi sono però riferimenti a isole e promontori e nomi come
Tycho, Copernicus, Plato, Hipparchus. Non è noto se questi si
riferiscano agli stessi crateri così denominati da Riccioli 40 anni
dopo, ma non possiamo escludere che il gesuita ferrarese fosse a
conoscenza del lavoro di Harriot.
In
seguito Harriot fece costruire i suoi telescopi dal suo assistente a
Syon House, Christopher Tooke, che ne realizzò da 8, 10, 20, 30 e
perfino 50 ingrandimenti, fornendone anche a Percy e Lower. Dopo
aver letto il Sidereus Nuncius di Galileo (pubblicato il 13
marzo 1610), Harriot e Lower tornarono a osservare la Luna con occhi
diversi. Il primo realizzò altri 18 disegni della superficie lunare,
17 fra il 27 luglio e il 4 novembre 1610 con telescopi da 10 e 20
ingrandimenti, e uno il 19 aprile 1611 con uno da 32 ingrandimenti.
I suoi disegni delle varie fasi lunari sono tecnicamente molto
inferiori a quelli di Galileo, poco più che schizzi, ma egli
realizzò anche delle mappe del nostro satellite, molto più fedeli
delle rappresentazioni galileiane per ciò che concerne la resa di
particolari realmente esistenti (fig. 11). Comunque i debiti di
Harriot e Lower emergono chiaramente da ciò che scrisse il secondo
nella lettera poco prima citata: “Penso che … Galileo abbia fatto di
più con le sue scoperte che non Magellano trovando lo stretto per il
mare del Sud … Nella Luna io ho osservato tempo addietro una strana
chiazzatura dappertutto, ma non sarei mai arrivato a concepire che
qualche parte di questa potesse essere formata da ombre.” E infatti
il primo disegno di Harriot dopo la lettura del Sidereus,
quello del 27 luglio 1610, è molto diverso da quello del 1609 e,
secondo la storica Terrie Bloom, si tratta in questo caso di un
esempio di “percezione derivata”, nel senso che sembra “troppo”
ispirato a uno di quelli pubblicati nel Sidereus: molto
simili le protuberanze che dalla parte luminosa si protendono nella
parte oscura, e il grande cratere in posizione mediana (fig. 12).
Somiglianze sospette anche perché il telescopio dell’inglese, pur se
più potente di quello usato per il primo disegno, era comunque
inferiore a quello presumibilmente usato da Galileo.
 Fig. 12.
A confronto il secondo disegno lunare effettuato da Harriot il 27
luglio 1610, a sinistra, e un disegno di Galileo apparso nel
Sidereus nuncius. Fig. 12.
A confronto il secondo disegno lunare effettuato da Harriot il 27
luglio 1610, a sinistra, e un disegno di Galileo apparso nel
Sidereus nuncius.
Probabilmente Harriot fu anche il primo a vedere le macchie solari
al telescopio. La sua prima osservazione solare è del 18 dicembre
1610. L’astronomo frisone Johannes Fabricius le vide per la prima
volta nel febbraio 1611 mentre la prima osservazione del gesuita
svevo Cristoph Scheiner è del marzo dello stesso anno. Quanto a
Galileo, in una lettera del 1631 che gli scrisse il padre Fulgenzio
Micanzio è riportato che il toscano le vide già nel luglio-agosto
1610, ma una testimonianza così posteriore, e proveniente da un
amico fidato su un argomento così scottante e che aveva già dato
adito a molte polemiche di priorità, non è probabilmente
attendibile. Tanto più che esiste il sospetto che l’affermazione
possa essere stata richiesta da Galileo per collegarla ad una
analoga contenuta nel Dialogo sui massimi sistemi, licenziato
nel 1630, pubblicato nel 1632. E probabilmente non molto più
attendibili debbono essere ritenute le autoattestazioni contenute
nella Prima lettera sulle macchie solari e nella lettera a
Barberini del 2 giugno 1612, anche perché in contraddizione con la
prima (la scoperta viene posticipata rispettivamente a novembre e
dicembre 1610). La prima prova sicura pro Galileo è dell’aprile
1611, in occasione di una sua visita a Roma, ed ebbe numerosi
testimoni. Tuttavia, anche in questa occasione, come ha mostrato
John North, Harriot, disegnando le macchie in modo molto schematico
(fig. 13), non realizzò la portata di ciò che stava guardando.
Soltanto dopo che nell’autunno 1611 Fabricius pubblicò le sue
osservazioni nel De maculis in sole observatis, affermando
che le macchie avevano un aspetto nebuloso e appartenevano alla
superficie di un sole in rotazione su se stesso, il matematico
inglese raffigurò le macchie come chiazze nebulose. Egli eseguì ben
199 osservazioni delle macchie solari, per oltre due anni.
Stranamente, benché conoscesse il metodo di osservazione tramite
proiezione, impiegato dagli altri astronomi, continuò sempre a
osservare il Sole direttamente attraverso il telescopio,
approfittando dei momenti in cui la sua luce era indebolita dalla
scarsa altezza e dall’immersione nella foschia o nella nebbia. Fino
all’11 dicembre 1611 sembra che non vi abbia più prestato molta
attenzione, perché registrò solo un’altra osservazione, il 29
gennaio. L’11 dicembre tornò a osservarlo perché era stato previsto
in quella data dall’astronomo italiano Giovanni Antonio Magini un
transito di Venere. Anche se la previsione si rivelò errata, da quel
momento Harriot lo seguì costantemente. Conformandosi alle opinioni
di Fabricius (e di Galileo) sulla natura delle macchie, comprese che
questo rafforzava le opinioni antiaristoteliche e costituiva un
argomento a favore di Copernico. Studiò l’evoluzione delle macchie
per diverse rotazioni solari, e misurò in poco più di 27 giorni il
periodo di rotazione.

Fig. 13. Le macchie
solari in due disegni di Harriot effettuati da Syon House il 6 e il
10 agosto 1611.
Harriot effettuò anche diverse osservazioni dei satelliti medicei. A
quanto risulta dalle sue carte, egli li osservò per la prima volta
solo il 27 ottobre 1610. Infatti, pur avendone avuto notizia nella
tarda primavera da Keplero o dalla lettura del Siderus nuncius,
Giove non si presentò in posizione favorevole fino all’autunno. Da
allora, fino al 7 marzo 1612, fece numerose osservazioni del
pianeta, talvolta misurando anche le distanze angolari dei satelliti
dal pianeta, anche se non è chiaro quale metodo usasse. D’altra
parte, gli storici ignorano ancora quale fosse il vero sistema
utilizzato da Galileo che, com’è noto, effettuò centinaia di queste
misurazioni.
Harriot produsse molti altri risultati nell’ambito della matematica.
In algebra introdusse una notazione semplificata, diversi simboli
che sono usati ancor oggi ed effettuò ricerche fondamentali sulla
teoria delle equazioni, che condussero a trovare soluzioni negative
e complesse anche di equazioni di grado elevato. Lavorò sulla
spirale logaritmica (cosiddetta perché le distanze fra i suoi bracci
aumentano in progressione geometrica), mostrando che era una
proiezione stereografica di una lossodromia (linea avente la
proprietà di tagliare tutti i meridiani con lo stesso angolo) su una
sfera, proiezione che egli dimostrò essere conforme (ovvero che
conserva gli angoli), e calcolò le lossodromie con grande
precisione, introducendo per questi calcoli l’interpolazione con
l’operatore per differenza finita.
Inoltre lavorò sulla bilancia idrostatica e intuì, prima di Keplero,
che le orbite dei pianeti non erano perfettamente circolari.
Intorno al 1613 Harriot cominciò a perdere interesse nello
sviluppare i suoi interessi matematici e scientifici: si manifestò
sul suo volto un’escrescenza carnosa, per la quale, nel 1615,
consultò i migliori specialisti. Una piaga cancerosa sviluppatasi
dalla narice sinistra si era via via accresciuta fino a consumare il
setto nasale, spingersi fino alle labbra e al resto del naso. Con
molta probabilità il male era collegato all’abitudine di fumare
tabacco, pianta che lui e Raleigh furono fra i primi a introdurre in
Inghiterra.
Il
suo morale, già provato dal male, fu messo a ulteriore dura prova
tre anni più tardi. Sir Walter Raleigh fu rilasciato nel 1616 per
guidare una spedizione in Venezuela alla ricerca dell’Eldorado, ma
attaccò senza autorizzazione un avamposto spagnolo, violando gli
accordi con la potenza straniera. Il conte di Gondomar, potentissimo
ambasciatore iberico a Londra, pretese dal re, e ottenne, la sua
condanna a morte, e sappiamo dalle cronache che all’esecuzione, l’8
novembre 1618, dovette assistere, in ossequio ai costumi del tempo,
anche il devoto amico ed ex pupillo Thomas.
Pochi giorni più tardi Harriot ebbe occasione di assistere
all’apparizione della più luminosa delle tre comete apparse quell’anno
(fig. 14). Ne compì almeno nove osservazioni, fra il 30 novembre e
il 25 dicembre. Fu veramente un evento memorabile, perché la testa
dell’astro raggiunse una luminosità tale da essere visibile in pieno
giorno, e la coda superò i 100° di lunghezza! Forse l’indole triste
e malinconica che, secondo molti storici, era tipica di Harriot,
aggravata dalle tragiche circostanze degli ultimi anni, dovette
fargli credere che era l’anima dello sfortunato amico che stava
tornando a farsi vedere nei cieli, e con la stessa grandezza,
nitidezza e splendore che aveva caratterizzato l’avventura terrena
del grande capitano.

Fig. 14. Due aspetti
della Grande Cometa del 1618, secondo le osservazioni dell’astronomo
svizzero Johann Baptist Cysat ( da Hevelius, Cometographia).
Infine, il tumore al volto ebbe ragione di Harriot, che morì nella
sua casa di Threadneedle Street, nel cuore di Londra, il 12 luglio
1621. Fu sepolto nella vicina chiesa di S. Cristopher, che fu
distrutta nell’incendio del 1666. Al suo posto si trova ora la sede
della Banca d’Inghilterra. Per fortuna, però, è sopravvissuta
l’iscrizione della pietra tombale, che nel 1971 è stata riportata su
una piastra di bronzo fissata a una parete della banca, sotto la
quale, da qualche parte, si trovano ancora i resti mortali
dell’illustre inglese.
Incredibilmente, di 35 anni di lavoro
originale Harriot, in vita, pubblicò solo il breve trattato sulla
Virginia. I suoi contributi di algebra, Artis Analyticae Praxis
ad Aequationes Algebraicas Resolvendas, apparvero solo dieci
anni dopo la sua morte, e fra l’altro in un’edizione non in grado di
valorizzare adeguatamente la profondità del suo approccio. Così, il
suo lavoro ebbe un’influenza molto inferiore a quella che avrebbe
potuto. E gli altri risultati in matematica, fisica e astronomia
circolarono soltanto fra gli amici e alcuni colleghi, per mezzo di
lettere, e principalmente in Inghilterra.
Sono state avanzate molte ipotesi per cercare di spiegare questa
riluttanza a pubblicare.
Sicuramente Harriot aveva un carattere piuttosto riservato e forse
timido, era un perfezionista, timoroso delle critiche. Inoltre
mancava dello zelo evangelico di un Galileo e, a differenza di
questi, non aveva una famiglia da mantenere. Aveva una cospicua
rendita assicurata, la sua vita era oltremodo agiata, e non aveva
quindi bisogno di ricercare la fama come un’assicurazione sulla
vita. Probabilmente però gli ostacoli più grandi alla pubblicazione
vennero da fattori politici: i tempi erano pericolosi e, soprattutto
dopo gli arresti di Raleigh e Percy e i suoi stessi guai giudiziari,
ritenne più prudente mantenere un basso profilo. Dobbiamo anche
ricordare, fra l’altro, come, dopo la Congiura delle Polveri, la sua
casa fosse stata ripetutamente perquisita dagli agenti del re in
cerca di prove di un suo coinvolgimento.
Il lavoro di Harriot venne alla luce
solo nel 1785 grazie a John Maurice, conte di Brühl, ambasciatore
sassone a Londra e all’astronomo ungherese Franz Xaver von Zach, in
visita in Inghilterra, che esaminarono le sue carte, riconobbero la
loro importanza, ne diedero notizia nell’Europa continentale e ne
raccomandarono la pubblicazione. Ma fu solo nel 1833 che gli inglesi
ebbero modo di conoscere il loro illustre predecessore, quando
Stephen Peter Rigaud, professore di astronomia a Oxford, preparando
per la pubblicazione le opere di James Bradley, astronomo reale dal
1742 al 1761, inserì come supplemento a queste una piccola parte dei
suoi lavori astronomici. E fu solo in quella occasione che vennero
rese note le sue osservazioni telescopiche.
I manoscritti originali di Harriot
sono conservati alla British Library, in seguito alla donazione del
1810 di Lord Egremont, e alla Petworth House nel Wiltshire. Nel
ventesimo secolo essi hanno ricevuto tutta l’attenzione che meritano
da parte degli storici della scienza, inglesi e non. Ma la loro
pubblicazione, che sembrava imminente negli anni Sessanta, è sempre
stata differita. Speriamo ardentemente che sia finalmente giunto il
momento che una più ampia cerchia di addetti ai lavori e di
appassionati possa conoscere integralmente il contributo di questo
grande genio dell’umanità.
|